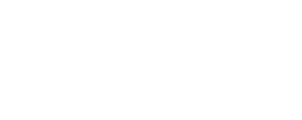Riportiamo con piacere l’intervento del Prof. Flavio Felice tenutosi in occasione della tavola rotonda intitolata “Dalla congiuntura socio-economica all’economia antropologica” del 22 giugno durante l’Assemblea UCID di Fano.

Istituzioni politiche e imprese
Flavio Felice[1]
Mi è stato chiesto di intervenire su quale dovrebbe essere il rapporto tra istituzioni politiche e imprese. Banalmente, possiamo dire che buona impresa e istituzioni sane si reggono a vicenda. Per buona impresa intendiamo un’entità economica che produce valore innovando e competendo, remunera i fattori produttivi, ha un impatto positivo sull’ambiente, favorisce la cultura della responsabilità, del diritto e della concorrenza. D’altro canto, un’istituzione politica è sana quando presuppone il primato del diritto (rule of law), favorisce un ordine civile dinamico attraverso la contendibilità delle cariche, esprime un potere limitato e controllato dal potere di altre istituzioni: il potere che limita il potere. È così che si stabilisce un circuito virtuoso, dove istituzioni sane favoriscono la buona impresa e questa favorisce istituzioni sane. In caso contrario, si innesca un circolo vizioso, dove istituzioni malate (estrattive) promuovono la cattiva impresa, quella di tipo predatorio, nella quale ad operare non sarebbero gli imprenditori, bensì meri prenditori, e questi ultimi assicurano la rendita politica delle élite; un reciproco sostegno che cristallizza le posizioni di potere.
Un secondo aspetto fondamentale da tener presente nella discussione è che non esiste un prius e un post tra buona impresa e sane istituzioni, esiste semmai un rapporto di dipendenza reciproca, delineando un quadro simbolico descritto dall’immagine geometrica del triangolo: ciascun lato regge l’altro e nessuno di essi può vantare di essere prevalente rispetto agli altri due; di fatto, se dovesse mancarne uno solo, verrebbe meno l’intera figura geometrica. Fuori di metafora, la reciproca dipendenza di impresa-istituzioni-responsabilità: economia, politica e cultura, ci invita ad una analisi politica ed economica culturalmente orientata ad un approccio pluralistico, che si contrappone ad uno di tipo monistico.
Seguendo l’approccio monistico, dovremmo immaginare la società come un tutt’uno, una massa indistinta di elementi che formano il tutto, inteso come realtà altra rispetto alle parti che la compongono: la società è una ipostatizzazione, una personificazione del tutto come soggetto in grande: il “gran-tous” di Rousseau, ma anche il Leviatano di Hobbes o l’“unum corpus mysticum” di Francisco Suarez (è evidente che parliamo di tre ipostatizzazioni differenti, ma accomunate da una identica rappresentazione del rapporto tra le singole parti e il tutto): il tutto è superiore alle parti che lo compongono, lo Stato è superiore al cittadino; l’interesse del partito è superiore a quello dell’iscritto; il bene superiore della razza è preordinato rispetto a quello del singolo essere umano; l’interesse per la ragion di Stato deve consentire il ricorso a pratiche ritenute inammissibili qualora considerassimo l’interesse individuale; in pratica, l’approccio monistico all’analisi sociale gerarchizza gli interessi, ordinandoli secondo il principio organicistico, in forza del quale saremmo tutti parti di un corpo, i cui organi sono funzione del tutto.
Se è indubitabile che un tale argomento riveste un fascino e una nobiltà antichi – si pensi soltanto all’apologo di Menenio Agrippa –, esso andrebbe riconsiderato alla luce del fatto che, mentre il tutto è un’astrazione, le parti che lo compongono sono qualcosa di molto concreto: sono le persone.
L’approccio pluralista o plurarchico, al contrario, fotografa una realtà sociale di tipo “poliarchico”: riconosce l’irrisolvibilità del pluralismo delle forme sociali, che genera una pluralità dei centri di potere: la “poliarchia”. Così come ciascuna persona sperimenta l’irriducibilità del suo essere persona ad una sola dimensione del suo esistere: la dimensione politica, economica, culturale, religiosa e via dicendo, possiamo dire altrettanto delle forme sociali. Non esiste un prius della politica rispetto all’economia, alla religione o ad altro, che rappresenterebbero un post, e viceversa. A questo punto, ogni forma sociale o centro di potere contribuisce quota parte e concorre all’interesse generale, senza che nessuno possa vantare alcun primato, dal momento che solo l’interferenza e la concorrenza tra le varie forme sociali e i differenti centri di potere sono garanzia che nessuno assuma un potere eccessivo.
È qui che entra in gioco il tema del “buongoverno” – ovvero dei “buoni governi” – rappresentati nel ciclo pittorico del Lorenzetti nella Sala dei Nove del Palazzo Pubblico di Siena. Abbiamo tre affreschi: l’allegoria del buongoverno, gli effetti del buongoverno, gli effetti del cattivo governo. Ebbene, che cosa caratterizza il buongoverno rispetto al cattivo governo? L’armonia tra i tanti buoni governi della città: commercio, artigianato, arte, cultura, politica, religione. In breve, non abbiamo una buona politica che, sovrana, regge saggiamente la città. Abbiamo invece una realtà in cui una politica limitata e controllata da altri governi consente a ciascun centro di potere di operare in una sfera limitata e, per questo, responsabile: non discrezionale. Potere politico e potere economico si controllano e si limitano a vicenda, garantendo le condizioni affinché le singole persone possano perseguire il proprio progetto esistenziale, favorendo la prosperità e la pace.
Prosperità e pace sono le condizioni generali fondamentali perché il bene comune non sia una formula vuota, ma il programma civile che ciascuna persona può perseguire. La prosperità è data dalla produzione di ricchezza in tutti i campi del vivere civile ed è necessario che provenga da differenti fonti e che raggiunga le svariate destinazioni, nella consapevolezza che la ricchezza è come l’acqua: è sana e portatrice di benessere quando scorre in modo ordinato, mentre è fonte di malattia quando ristagna ed è causa di distruzione quando, non incanalata, invade il territorio in maniera torrenziale. D’altro canto, la pace non è mera assenza di guerra: è l’agostiniana “tranquillitas ordinis”, la risultante dell’armonizzazione dei tanti organi civili presenti nella società, tale da rendere impraticabile la guerra e persino impensabile che qualcuno possa ricorrervi: un anacronismo della storia.
Pace e prosperità sono le condizioni istituzionali che dipendono da una predisposizione civile al pluralismo sociale e, a loro volta, sono l’indispensabile nutrimento di quella predisposizione: “tranquillitas ordinis”, affinché non prevalga la tentazione di affidarsi alla pretesa funzione taumaturgica della politica, all’infondata credenza circa l’innata efficienza dell’impresa, alla presunzione perfettistica di una religione o di una ideologia. Pace e prosperità sono artefatti umani, manufatti istituzionali che richiedono l’impegno e l’umiltà che segnano la distanza tra la “civitas Dei” e la “civitas hominum”.
[1] Professore ordinario di Storia delle dottrine politiche, Università del Molise